
Ode al vampiro
nobile e malinconico
Dal Quotidiano dell’8 febbraio 2007
nel testo dell'antropologo vito teti

Ode al
vampiro
nobile e malinconico
di SONIA SERAZZI
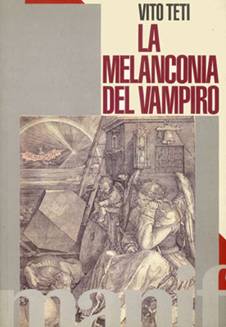
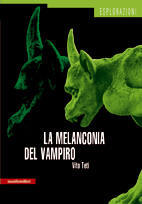 Una leggenda
talmudica racconta che il pipistrello non fu ammesso a bordo della salvifica
arca di Noè: al nero uccello notturno è precluso lo scampo, il rifugio, il
riparo. Uguale sorte disperante tocca al vampiro, che talvolta in pipistrello si
muta.
Una leggenda
talmudica racconta che il pipistrello non fu ammesso a bordo della salvifica
arca di Noè: al nero uccello notturno è precluso lo scampo, il rifugio, il
riparo. Uguale sorte disperante tocca al vampiro, che talvolta in pipistrello si
muta.
Mi pare questa salvezza impossibile il risvolto vibrante del saggio di Teti
sulla malinconia del vampiro, un libro denso sull'evoluzione di una figura
folklorica che assume spessore archetipico per la cultura moderna e postmoderna.
Dall'Europa illuminista, il vampiro - lemure inquietante che brama la vita
d'altri per vincere la propria morte - risale ammansito e trasfigurato fino alla
contemporaneità, così un corpulento spettro avido di carne e sangue si fa
emaciato dandy nella letteratura ottocentesca, e fascinosa autorappresentazione
di molti intellettuali tormentati dei giorni nostri.
Confesso d'essere grandemente turbata da inestirpabile avversione per i cadaveri
viventi: rispetto i soffi lievi e giocosi degli spiriti e il loro timido
avvinghiarsi ai sogni, ma non concedo altro alle ombre. Più generoso di me, Teti
fruga il mondo infero e addita il pozzo necrofilo da cui la cultura
contemporanea pesca perturbanti figure di revenants che scoperchiano avelli per
nostalgia dell'esistere: una sollevazione di anemici che sperano dalle vittime
il sangue di cui sono sprovvisti. In tal senso, il malinconico vampiro di Teti
raffigura degnamente una contemporaneità incentrata sulle modalità
di fruizione succhia-e-sputa, che non arretrano neanche davanti all'orrore di
corpi feriti morenti e squarciati raccolti dai televisori. L'oscura inquietudine
del vampiro - di cui Teti scorge lucidamente le potenzialità di destrutturazione
dell'agire seriale e irriflesso - degenera in compulsiva e famelica iperattività:
la moltiplicazione del desiderabile compensa vacuità ostentate con compiacimento
mondano, quasi che al vuoto spetti l'onore dell'abissale profondità, invece che
il rapido turarsi il naso che di norma meritano le fogne a cielo aperto.
Già Guido Ceronetti - in un articolo ripreso da Teti - disocculta la natura
commerciale dei contorcimenti vampirici dei nostri tempi. I vampiri di Ceronetti
succhiano musica e pubblicità, mordono bambole di gomma e amano i loro scaltri
allevatori. Il vampiro postmoderno è tacchino d'allevamento costretto in gabbie
illuminate full time, perché la costante esposizione agli stimoli moltiplichi
gli appetiti e le conseguenti escrezioni. Intestini ipercinetici e onnivori
divorano e defecano orali e scritti, in una contaminazione del gusto che alza la
soglia di tolleranza dell'orrore: tutto è digeribile, purché scuota appena anime
stagnanti
ridotte a contemplarsi l'ombelico.
Ho letto in prestito "Zoo" di Isabella Santacroce: il padre della protagonista
muore d'infarto, la protagonista precipita dalle scale e guadagna una sedia a
rotelle sulla quale si svaga torturando la madre, infine - consumato un
incestuoso rapporto saffico con la genitrice - la funesta paraplegica si libera
di chi l'ha partorita soffocandola col cuscino. La tormentata scrittrice narra
il letame sguazzandoci meglio che nei fanghi termali, e alle parate televisive
di cui si pasce esibisce un eterno volto cupo e sofferente. Sul grazioso musetto
imbronciato della tenebrosa fanciulla spicca sempre un rossetto infuocato:
irrinunciabile cosmetica del soffrire.
Ben più seria, la scrittrice inglese Sarah Kane - in "Psicosi delle 4.40" -
scrive: "Tutto passa/ tutto muore/tutto viene a noia." Quasi l'urlo delirante di
una coscienza frammentata da eventi agiti, subiti e osservati. "Come faccio a
fermarmi?" si domanda ossessivamente Sarah Kane. E si risponde suicidandosi a
ventott'anni: coerentemente. Per contro, i colleghi quaquaraquà della Kane si
pagano la pagnotta inscenando letterari squartamenti e carni varie maciullate
amputate e insaccate. Intanto la sfangano, di libro in libro.
Quello indagato da Teti ne "La malinconia del vampiro" è vampiro raffinato e
sensibile, melanconico che si strugge d'amore indolenzito e tragicamente negato.
I banali vampiri delle cronache sterminano i vicini caciaroni, succhiano il
sangue delle stragi da schermi al plasma o romanzano la ferocia celebrandola. Di
questi vampiri che sfruculiano compiaciuti il sanguinolento, Teti scava le
radici più nobili, e solo ad esse volge lo sguardo: una saggezza inattuale di
cui i lettori di classici gli saranno grati.
ALCUNI BRANI
La figura del vampiro dal folklore
dell’Europa centrosettentrionale alle dispute settecentesche, dalla letteratura
romantica alla psicoanalisi, dal cinema all’industria culturale, dai fumetti a
internet. Presente in innumerevoli paesi e tradizioni locali, legato alla
credenza nel ritorno dei defunti e alla concezione del sangue come elemento di
morte e di vita, dilagante nei periodi di più traumatica transizione storica, il
morto non morto accompagna tutto il corso della modernità. Segno di
contraddizioni inconciliabili, questo prigioniero della notte incarna la
condizione di un soggetto ormai pienamente esposto allo sradicamento e alla
precarietà. Tragica parodia dell’eterno ritorno in un mondo governato dal tempo
lineare, né vivo né morto, costretto a distruggere ogni oggetto del suo
desiderio, il vampiro assume, nell’immaginario colto e popolare, i tratti
dell’afflizione e del sentimento melanconico che hanno segnato la tradizione
dell’Occidente dall’antichità ai nostri giorni. Oggi il vampiro si presenta come
l’ultimo abitante e la metafora delle rovine postmoderne, al tempo stesso
annunciate e inimmaginabili – da Chernobyl a Beirut, dall’ex Jugoslavia a
Baghdad e alle Twin Towers – e sembra raccontare paure e speranze legate ad
un’inedita angoscia di fine del mondo e ad un nuovo sentimento degli altri e dei
luoghi.
PRESENTAZIONE
RITORNANO, PRIMA O POI
I vampiri, assumendo connotati diversi, ritornano, prima o poi.
Anche i libri sui vampiri – così immaginano e sperano, probabilmente, i loro
autori – hanno una qualche possibilità di ritornare, di non morire.
Il ritorno di questo libro è dovuto al fatto che la prima edizione è
praticamente introvabile e continua ad essere richiesta da più parti. La figura
del vampiro insiste a offrire elementi di riflessione per capire il senso o il
non senso di aspetti culturali caratterizzanti quella che, con buona
approssimazione, chiamiamo tradizione occidentale.
Ho faticato, alquanto, per addomesticare la tentazione di aggiungere, rivedere,
precisare, tenendo conto, anche, della vasta letteratura apparsa negli ultimi
anni sugli argomenti trattati, oltre che dei mille avvenimenti accaduti
nell’arco di oltre un decennio. Mi sono reso conto che avrei finito con lo
scrivere un altro libro e, dunque, mi sono limitato, oltre che a pochi
indispensabili ritocchi e integrazioni, all’aggiunta di un nuovo paragrafo, che
dà conto parziale della più recente fortuna del vampiro nell’immaginario
dell’Occidente.
I ritorni, in fondo, non sono mai del tutto possibili. Non sono mai «ritorni»
all’origine, acquistano sempre un altro senso da quello pensato e dichiarato.
Ogni ritorno rappresenta sempre una novità.
IL REVENANT DALLA TRADIZIONE AL MODERNO E AL POSTMODERNO
Le definizioni del vampiro sono numerose e il termine spesso indica figure
diverse. Non sarebbe inutile una contestualizzazione, geografica, territoriale,
antropologica del revenant di cui si parla. Il vampiro, «morto-non morto» che
ritorna per disturbare, contagiare, uccidere i vivi, spesso succhiando loro il
sangue, non può essere separato dalla paura del ritorno, perturbante e
pericoloso, dei defunti, presente in tutte le società arcaiche, tradizionali e
primitive. I morti nelle diverse culture sono stati considerati, temuti,
affrontati, in un certo senso, come «entità ostili», come possibili vampiri.
In quanto legato alla paura della morte e alla nostalgia della vita, al culto
dei defunti e al timore che possano tornare, spesso a concezioni del sangue come
elemento di vita e di morte, il vampiro si presenta come una sorta di archetipo,
come una figura ricorrente, con caratteri e comportamenti diversi, in tutte le
culture e le società tradizionali. Appare, pertanto, plausibile, ma abbastanza
problematico, tentare di individuare le origini e i caratteri costitutivi del
fenomeno che nel Settecento sconvolge intere comunità dell’Europa
centrosettentrionale prima di contagiare i salotti, le gazzette, l’immaginario
delle principali città europee (Londra, Parigi, Vienna, Napoli, Palermo), dove
viene accolto e reinventato anche con immagini e motivi presenti nelle culture e
nelle tradizioni locali.
Le ipotesi sulla provenienza geografica e sull’origine culturale del moderno
vampiro sono diverse. Gli studiosi hanno rintracciato dovunque figure e motivi
vampirici che poi sarebbero confluiti nella configurazione del moderno vampiro.
Anche i legami tra vampiri, lupi mannari, sciamani, streghe – tutte figure che
raccontano un legame tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, una continuità
tra vita e morte – sono molteplici e sembrano rinviare ad un analogo sostrato
culturale arcaico. E tuttavia fenomeni come il vampirismo, la possessione
diabolica o degli spiriti, lo sciamanesimo, la caccia alle streghe, il
licantropismo, il cannibalismo rituale e non – con evidenti somiglianze – si
sono presentati, nella storia e nelle tradizioni di diverse aree geografiche,
con una diversità che soltanto molte invenzioni postmoderne hanno saputo
mescolare e confondere.
La questione decisiva, però, uscendo da congetture, ipotesi, ricostruzioni
sempre in qualche modo fondate, che mi sono posto in questo lavoro è stata
quella di ripensare come e quando il motivo della paura dei defunti che
ritornano come vampiri, diffuso in contesti geografici, storici e culturali
lontani, abbia dato origine, insieme ad altri elementi e ad altri fattori, «una
e una sola volta nella storia» complesso, drammatico fenomeno storico di diffuso
e spaventoso ritorno di vampiri. Mi sono posto, in altri termini, il problema di
come e perché l’Occidente colto e illuminato, quello dei filosofi e quello degli
uomini di Chiesa, che si interrogavano sulle superstizioni popolari, abbia
«scoperto» il vampiro.
La grande epidemia vampirica (che si concludeva con dissotterramento di cadaveri
e una nuova «uccisione» con il paletto nel cuore a cui seguiva di solito la
cremazione) degli anni Trenta del Settecento in Ungheria, Moldavia, Slesia,
Polonia aveva infatti accompagnato, in maniera drammatica, la fine di un antico
universo, aveva segnato, in maniera talora cruenta e raccapricciante, l’erosione
e la fine delle società tradizionali e l’affermarsi delle concezioni moderne.
Il contagio settecentesco è all’origine delle invenzioni, delle elaborazioni,
delle mitizzazioni colte del secolo seguente. È possibile individuare in quella
violenta e improvvisa esplosione gli ultimi rumorosi «strepiti» di un mondo in
agonia, l’esito finale della drammatica lotta che l’illuminismo e la Chiesa
cattolica (e anche quella ortodossa) conducevano, in diverse forme, contro le
superstizioni popolari e le concezioni arcaiche. Un fenomeno unico e
irripetibile, che ha accompagnato il crepuscolo di culture tradizionali
millenarie e ha segnato il controverso affermarsi della modernità.
Il vampiro delle superstizioni popolari dell’ancien régime, a dispetto delle
previsioni degli illuministi, tornava ben presto sotto nuove vesti, si
guadagnava una nuova vita. Si trasferiva, con eccezionale capacità di
trasformazione, nella cultura colta e nel nuovo folklore europeo, e contagiava
la produzione letteraria, teatrale, artistica di molti paesi, si diffondeva nei
centri di quella modernità che avrebbe dovuto allontanare paure, tenebre e
ignoranza.
All’inizio dell’Ottocento il vampiro si incarna, in maniera inquietante,
nell’eroe fatale e romantico di ascendenza byroniana. Soprattutto dopo The
Vampyre (1819) di John William Polidori, il vampiro diventa una figura forte
delle costruzioni letterarie dei romantici. Negli anni Venti dell’Ottocento non
c’è a Parigi un teatro – così scrivono i giornali dell’epoca –, che non metta in
scena un vampiro. A partire da quel periodo, moltissimi scrittori e poeti
vengono attratti dalla figura del vampiro. Il termine vampiro diventa metafora
di tante figure, positive e negative, del male assoluto, del diavolo, del
cannibale, del capitalista, ma anche dell’artista, del flâneur, dell’errante,
del seduttore, dello straniero, dell’esule, dell’emigrante. Vampirizzare diventa
un verbo riferito alle situazioni più varie.
Questa grande dilatazione del termine è possibile perché la figura del vampiro
si afferma in una tradizione culturale nella quale la melanconia e le rovine, a
cui è strettamente connessa, avevano una storia di lunga durata e si
apprestavano a raccontare il lento affermarsi del moderno. [...]